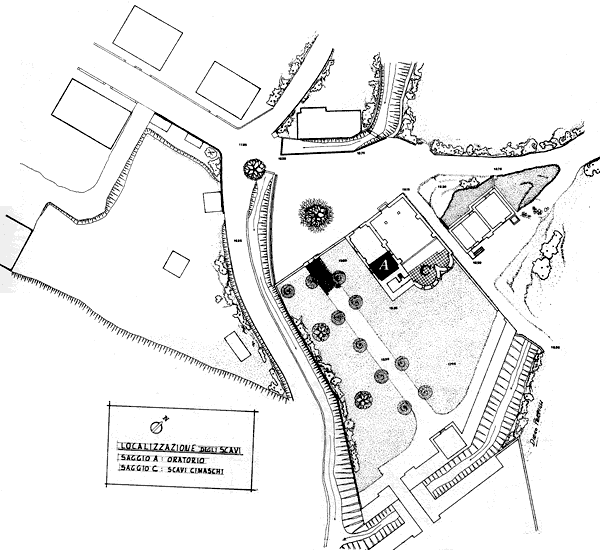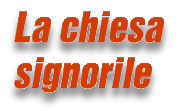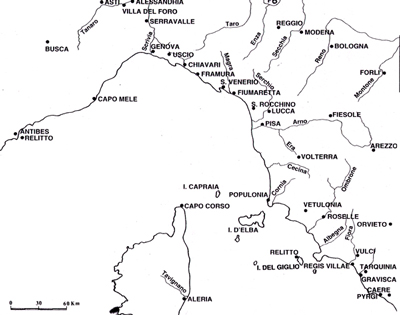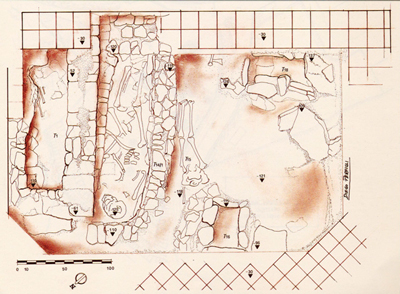|
|
|
|
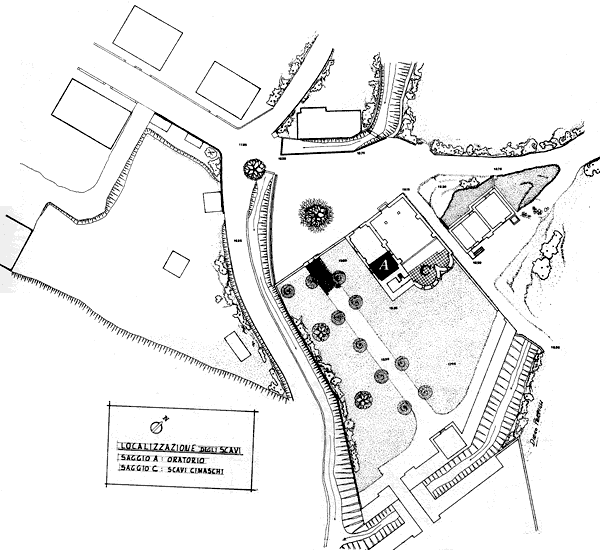 |
|
|
 |
|
 |
|
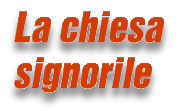 |
|
|
|
|
Planimetria dell'edificio ecclesiale, dell'oratorio e torre, con
indicazione degli scavi archeologici (1985)
|
|
La chiesa di San Venerio di Migliarina, che -seppur priva ormai
di funzioni parrocchiali- è ancor oggi detta localmente "la Pieve",
è dedicata ad un monaco eremita vissuto secondo la tradizione
fra VI e VII secolo nell'isola del Tino, di fronte a Portovenere.
Le sue reliquie sarebbero state poi traslate, circa alla metà
del secolo VII, nella chiesa di terraferma, e più di due secoli
dopo, a causa delle incursioni saracene, trasportate per maggior
sicurezza a Reggio in Emilia.
Il sito della presunta deposizione, oggi nel Comune della Spezia,
fino agli inizi del Novecento parte della distrettuazione di Vezzano
Ligure, fu fatto oggetto di un rinnovato fervore di culto nella
metà del secolo XI, allorché la chiesa antica, che la tradizione
dice esser stata distrutta, venne ricostruita nelle attuali forme
protoromaniche. In un atto del 1084, quasi un certificato di nascita
del nuovo edificio sacro, i signori locali, i Vezzano, che prendevano
nome dall’omonimo castello fonte del loro potere, ne dispongono
la ricostruzione, facendone quasi un santuario di famiglia, affidato
al monastero di San Venerio del Tino.
La chiesa romanica adotta una partitura mononavata con due absidi
(secondo la tipologia delle cosiddette biabsidate, connesse con
un culto reliquiario) in una progettazione che vede come modulo
di base il diametro di un’absidiola di un precedente edificio
cultuale, databile all'altomedievo, i cui lacerti sono rintracciabili
nelle fondazioni della chiesa romanica.
Si appoggia ad una massiccia torre campanaria antecedente di circa
50 anni, che disinvoltamente reimpiega nelle decorazioni del paramento
murario laterizi romani e rivela una scala in spessore murario,
del tutto eccezionale per l’epoca.
|
|
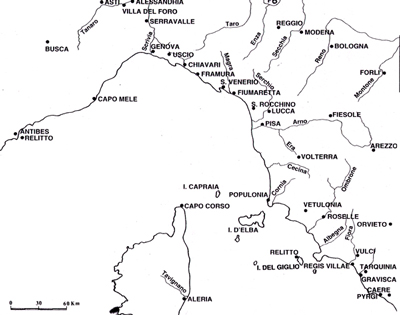 |
|
|
|
 |
|
I siti delle rotte commerciali etrusche nell’alto Tirreno (da
Bonamici, in “Studi Etruschi”)
|
|
L’edificio sorge, circondato come in antico da un cimitero, ai
piedi dei rilievi collinari della costiera orientale del golfo
della Spezia, sul ripiano di confluenza, in declivio, di due fossati
che discendono dalla displuviale del monte Boverone.
Si tratta di un'area percorsa da un'antica viabilità di collegamento
fra la vallata della Magra e i tracciati viari a mezzacosta del
lato orientale del golfo, raccordabili ad una viabilità marittima.
Negli anni '80 è stato infatti rinvenuto materiale ceramico che
attesta, nell’area più a monte della chiesa, la presenza di un
insediamento dell'età del ferro finale (VI sec. a. C.), aperto
anche a scambi commerciali con l'Etruria, da cui s’importava ceramica
pregiata come il bucchero pisano, tappa perciò di un itinerario
marittimo che giungeva nel nostro golfo.
La successiva colonizzazione fondiaria romana, promossa probabilmente
dalla vicina colonia di Luni già nel sec. I a. C., è confermata
dalla toponomastica (l’area si chiamava Antoniano, toponimo prediale),
e da un robusto muro di recinzione in opus incertum, di epoca
tardo repubblicana, raffrontabile con un consimile nella villa
rustica del Varignano: esso è ancor oggi visibile, grazie ad una
botola, a livello delle fondazioni della chiesa romanica.
È stata anche fatta l’ipotesi che la zona sia da identificarsi
con il sito Boron della Tabula Peutingeriana, la famosa carta di percorsi stradali
di epoca tardo-romana, per l’assonanza Beverone- Boron, attraverso la forma medievale castrum Boveronis - Borono, ma oggi, sulla base di documentazione medievale genovese, essa
non è più sostenibile.
La costruzione e la seguente devozione per l'edificio sacro protoromanico,
con però una tradizione cultuale e funeraria risalente all'altomedievo,
provocarono una ridotta concentrazione di popolazione e un incastellamento
non lungi dal luogo sacro, tanto che dal secolo XII la zona è
chiamata villa Sancti Venerii. Promossa a pieve, a chiesa cioè battesimale, fulcro della organizzazione
gerarchica vescovile, e inserita nella circoscrizione diocesana
Lunense, nel quadro del riassetto dei territori e possessi vescovili
del XII secolo, avrà sempre poche cappelle dipendenti e scarso
sviluppo territoriale. La crescita del vicino insediamento di
Migliarina con la chiesa di San Giovanni, un tempo dipendente
dalla pieve, apporta la dizione attuale di San Venerio di Migliarina,
usata almeno a partire dal sec.XVIII.
|
|
|
 |
|
 |
|
|
Muro romano sotto l'abside maggiore
(scavi Cimaschi 1959)
|
Tomba altomedievale sotto il presbiterio
(scavi Cimaschi 1959)
|
|
|
|
|
|
 |
|
A partire dal secondo decennio del Novecento, la storiografia
lunigianese, in particolare Ubaldo Mazzini e Ubaldo Formentini,
ha rivolto il proprio interesse all'ente religioso, facendone
una delle basi alle problematiche della ricerca sulle prime fondazioni
ecclesiastiche cristiane, sul problema della continuità dal sistema
circoscrizionale pagense al pievano. Nel quadro degli interventi
di restauro, e seguenti studi di archeologia cristiana per il
golfo della Spezia, condotti al monastero dell'isola del Tino,
al Tinetto, a Portovenere fra il '52 e il '61, anche la pieve
di Migliarina fu oggetto, in occasione della rimozione della pavimentazione
della navata, di scavi archeologici condotti da Leopoldo Cimaschi
nell'area presbiteriale; si mise così in luce una sequenza pluristratificata
di strutture, che trovavano una coincidenza con le informazioni
- e suggestioni- provenienti dai documenti scritti, specie agiografici.
Negli anni '80 si procedette ad una revisione, un nuovo rilievo
e ad analisi delle tecniche e dei materiali congiunta con quella
sedimentologica delle malte, in funzione di una rilettura delle
unità stratigrafiche murarie dell'area scavata, ancora raggiungibile
sotto il moderno altare; quindi ad un field survey nell'adiacente
vallecola e ad uno scavo su concessione ministeriale, diretto
dalla scrivente, nel contiguo oratorio insistente su una necropoli
medievale (secc.XI-XVI).
Eliana M. Vecchi
|
|
|
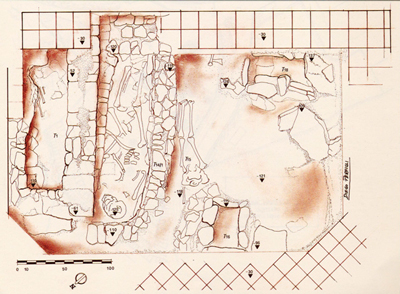 |
|
|
|
 |
|
|
Settore Oratorio, planimetria delle sepolture medievali (scavi
Vecchi 1985)
|
|
MAZZINI U., Per i confini della Lunigiana, in "Giornale storico
della Lunigiana", I (1909), pp. 4-38
MAZZINI U., Epigrafi romane di Lunigiana. Nella Pieve di San Venerio,
in "GSL", V (1913), pp. 57-61
CONTI M. N. , Chiese medievali a due navate in Lunigiana, in “Memorie
dell’Accademia Lunigianese di Scienze e Lettere «G. Capellini»”,
VIII (1927), pp. 7-22
FORMENTINI U.., San Venerio, in “ MALC ”, XVIII (1937), pp.26-47
FORMENTINI U., Luna - Boron - Veleia, in Atti e memorie del primo
convegno di studi storici e archeologici (Piacenza-Velleia: 29-30
maggio 1954), Piacenza1955, pp. 189-196
PISTARINO G., Le pievi della diocesi di Luni, Bordighera, La Spezia
1961
CIMASCHI l., La prima campagna di scavo alla pieve di S.Venerio
, in “GSL”, n.s.XII (1961), pp. 23-46
MARMORI F., Su alcune chiese a due navate nella Riviera di Levante.
Contributo allo studio del tipo, in “ Quaderno n.7”, Genova nov.
1971, pp.116-117.
GOLINELLI P., Culto dei santi e vita cittadina a Reggio Emilia
( secc. X-XI), Modena 1980
PISTARINO G., Storia e leggenda di San Venerio del Tino, in Storia
monastica ligure e pavese, Italia Benedettina V, Cesena 1982,
pp.11-38
PETTI BALBI G., I signori di Vezzano in Lunigiana (secoli XI-XIII),
La Spezia - Massa Carrara 1982
LUSUARDI SIENA S., Lettura archeologica di un territorio pievano:
l’esempio lunigianese, in Cristianizzazione ed organizzazione
ecclesiastica delle campagne nell’alto medioevo: espansione e
resistenze, Settimane del Centro italiano di studi sull’alto medioevo
(Spoleto, 10-16 aprile 1980), Spoleto1982, pp. 301-334
VECCHI E.M., La pieve di San Venerio di Migliarina. Nuovi contributi,
in Atti del VI Congresso Nazionale di Archeologia Cristiana, Pesaro-
Ancona 1983, Ancona 1985, pp.843-860
C. DUFOUR BOZZO, L’architettura ecclesiastica: note per un bilancio in prospettiva, in Atti del convegno “ San Venerio del Tino…”, cit., pp.329-339 AMBROSI A.C.,
CARROZZI F., Appunti per servire allo studio della viabilità medioevale nel territorio spezzino, in Atti del Convegno "S. Venerio del Tino: vita religiosa e civile tra isole e terraferma in età medievale (Lerici-La Spezia-Portovenere: 18-20 settembre 1982), La Spezia-Sarzana, Istituto internazionale di studi liguri, 1986, pp. 25-42,
POLONIO V., L’organizzazione ecclesiastica, in Atti del convegno
“San Venerio del Tino…”, cit., pp. 113-133.
VECCHI E.M., La chiesa di S. Venerio in Antoniano, in Atti del
convegno “San Venerio del Tino…”, cit., pp. 249-308
VECCHI E.M., Fra architettura religiosa e difensiva: le torri
campanarie isolate, in Società civile e società religiosa in Lunigiana
e nel vicino Appennino dal IX al XV secolo, Atti del Convegno,
Aulla 1984, Aulla 1986, pp. 191-234
VECCHI E.M., Migliarina, in Archeologia in Liguria, III,2, Scavi
e scoperte 1982-5, Genova 1987, pp.245-7
RONCO D., FORNACIARI G., MALLEGNI f., studio antropologico dei
resti scheletrici di S. Venerio eremita, in "GSL", n.s. XLI-XLII
( 1990-1)
M. BONAMICI, Contributo alle rotte arcaiche nell’alto Tirreno,
in “ Studi Etruschi”, s.3°, LVI (1995), pp.3-42
|
|
|
|
La Spezia, 2001 - Edizioni Giacché, La Spezia - Powered by Ampersand
srl, La Spezia
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|